I figli crescono, e lo fanno in silenzio. A volte basta una notte, a volte un’estate intera e qualcosa cambia per sempre: la voce, lo sguardo, il modo in cui ci lasciano sempre più spesso la mano. Nel frattempo, noi padri proviamo a tenere il passo. Questa newsletter cambia forma per seguirli: quattro punti di vista, quattro età diverse dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il primo numero era nato come un biglietto lasciato sul tavolo della cucina, la mattina della mia prima festa da papà. Questo secondo numero arriva in un altro tempo e in un’altra direzione: è il giorno della festa della mamma, e a loro, oggi, vanno i nostri auguri. Intorno, il tempo sembra disegnare cerchi, trame invisibili che si rincorrono sulla superficie della quotidianità come riflessi su vetri levigati dal mare e lasciati sulla battigia. Ogni genitore lo sa: bastano pochi respiri, una stagione che cambia, e quel figlio che credevamo finalmente di conoscere ci appare diverso. Più alto, più lontano, o solo un po’ più indipendente.
Così abbiamo rimesso mano a tutto. Non per rifare, ma per guardare meglio. Abbiamo scelto di raccontare l’essere padri da quattro prospettive diverse, in quattro fasi della crescita, con lo stesso sguardo di sempre: attento, inquieto, affettuosamente disordinato. Non abbiamo risposte, solo domande che cambiano con loro, e con noi.
Marco Bisanti racconta i dialoghi con suo figlio Artù, cinque anni. Sono conversazioni che custodiscono mondi: domande che iniziano con i dinosauri e finiscono nel cosmo, passando per la meccanica delle macchinine e il mantello di Batman. In quell’incanto dell’infanzia, dove ogni parola può essere filosofia.
Marco “Zak” Marincola naviga le acque incerte dell’adolescenza. Il suo è un equilibrio instabile tra piuccheperfetti, aoristi greci e silenzi improvvisi, tra vocabolari e parole non dette. Scrive da una soglia difficile: quella in cui i figli smettono di cercare conferme e a mettere distanza. E in quella distanza, prova a restare.
Alessandro Buttitta insegna e osserva, da entrambi i lati della cattedra. La scuola diventa, per lui, un doppio osservatorio: sui figli degli altri, e un po’ anche sulla sua.
E poi ci sono io, che provo ogni giorno a rispondere a mio figlio nel nitore dei suoi due anni, tra un “cus’è?” e un altro. Ci sono giorni in cui le domande sembrano non finire mai, e giornate che passano così, intere, in quel labirinto di richieste senza punteggiatura. Ma c’è sempre una domanda in cui scivoliamo insieme nel sonno: “Sei felice?”. E la risposta, squillante e certa, basta a tenere insieme tutto il resto.
Siamo ancora qui per raccontare che essere padri oggi significa restare in ascolto anche quando non si ha più voce, continuare a cercare parole quando tutto cambia. Questo è un luogo dove lo facciamo insieme.
Benvenuti nel nuovo numero di questa seconda stagione di Padri in formazione. Si riparte da qui.
Batti cinque
di Marco Bisanti
- Sai che cosa mangiavano i tirannosauri?
- Che cosa?
- Fusilli al pesto.
Se non assegno i turni al dialogo è impossibile dire chi ha detto cosa, tra me e mio figlio. I più mi darebbero nell’unica battuta in mezzo, in mezzo al mondo di Arturo che mi dà un’info ancora ignota alla tradizione paleontologica. Stasera, invece, era lui a stare in mezzo e io in buona forma, in ascolto del suo fuoco. La lentezza con cui scava ere geologiche tra un boccone e l’altro era amplificata da un gioco sui dinosauri, trovato nel pomeriggio dentro un ovetto.
Non ce la facevo più. Caso raro a fine giornata però, sono riuscito a convertire la frustrazione in ironia. Mescolare le carte tra fantastico e reale è frequente per un genitore. Riuscire a farlo da conduttore del gioco, e non mera spalla distratta, inventando un gancio per intendere ben altro nella realtà condivisa al momento, è degno di menzione. Gli è nato un sorriso che ha fatto risorgere il sole, spaesando il buio fuori e l’ordinaria collocazione temporale della cena. E facciamoli ogni tanto complimenti del genere a noi stessi.
Anche perché è accaduto nella stessa settimana in cui mi sono detto più volte che proprio non sono fatto per fare il padre. Non sono cosa, mi dicevo l’altro giorno misurando i miei stati e l’accordatura della voce o la relativa mimica, in tutta la loro incongruenza rispetto a ciò che di solito immagino comprenda il mio ruolo. Come se ci fosse vero un galateo del genitore e non, invece, solo uno spettro alimentato dalla bufera di slogan disinvolti che pullulano nel web dei consigli e delle condivisioni, tra persone che hanno scelto di crescere e accudire altre vite.
Facciamo schifo invece, dai: diamo più cittadinanza a questo, senza nascondere le nostre miserie. Ma siamo anche meravigliosi, capaci di far nascere un sole improvviso all’ora di cena. E non perché siamo noi, degni. È il sole che ci chiama per nome. Sentite?
Teen wars
di Marco Zak
Papà prof
di Alessandro Buttitta
Recentemente, in classe, ho assegnato una traccia ai miei studenti. Riassumo per esigenze di spazio. “Cosa insegneresti ai tuoi genitori? Scegli qualcosa che hanno dimenticato, che ignorano o che non hanno mai appreso”. Le risposte, numerose, talvolta persino toccanti, hanno fatto emergere con forza un bisogno comune: quello di essere percepiti correttamente.
Molti ragazzi hanno descritto la frustrazione nel vedere i propri problemi, le proprie difficoltà emotive, sminuiti o liquidati senza troppi fronzoli. “Alla tua età non si hanno problemi” oppure “Finiscila, non sono questi i problemi della vita”, per fare qualche esempio. Un segnale chiaro di un disagio profondo: quello di non sentirsi visti e validati nelle proprie fatiche dai genitori.
La prospettiva adulta, le pressioni della vita quotidiana, possono involontariamente portarci a minimizzare queste loro esperienze. Confrontiamo le loro ansie, le loro delusioni o le loro paure con la nostra scala di "veri problemi", e la misura sembra impari. Raramente è cattiva intenzione; più spesso è un filtro deformante, frutto della nostra esperienza passata, della fretta o della semplice fatica di fermarci e sintonizzarci davvero sulla loro lunghezza d'onda.
L’effetto di questa svalutazione, però, è profondo. Un figlio che si sente costantemente sminuito nelle sue emozioni impara presto a tacere, a non condividere più. La solitudine si annida dove la condivisione autentica viene scoraggiata. La comunicazione si logora e, con essa, si logora anche la fiducia. I ragazzi si sentono dire che i loro problemi "non esistono", ma il loro malessere, la loro fatica di crescere, sono assolutamente reali.
Qui si inserisce il ruolo cruciale del padre consapevole, del padre “in formazione”. La chiave di volta è trasformare questi problemi sminuiti in difficoltà condivise. Sembra facile, ma non è lo è. Possiamo parlare di ascolto attivo, ma sappiamo bene quanto sia arduo e complicato un atteggiamento di questo genere, soprattutto in un'età come la nostra così contraddistinta dalla distrazione. Non si tratta di fornire soluzioni preconfezionate o giudizi affrettati. Si tratta, prima di tutto, di creare uno spazio di accoglienza autentica dei nostri figli.
Ascoltare attivamente significa comunicare, con le parole e con la presenza fisica e mentale. Ciò non implica assolutamente approvare ogni comportamento o concordare sulla gravità oggettiva del problema, ma riconoscere la legittimità della loro esperienza interna, del loro vissuto soggettivo. Un simile approccio sposta radicalmente il focus: il problema del figlio, piccolo o grande che sia per la nostra lente adulta, diventa un’occasione di incontro e di connessione, non di scontro o svalutazione. È un segnale potente che va cercato, con tutta la fatica che ne consegue.










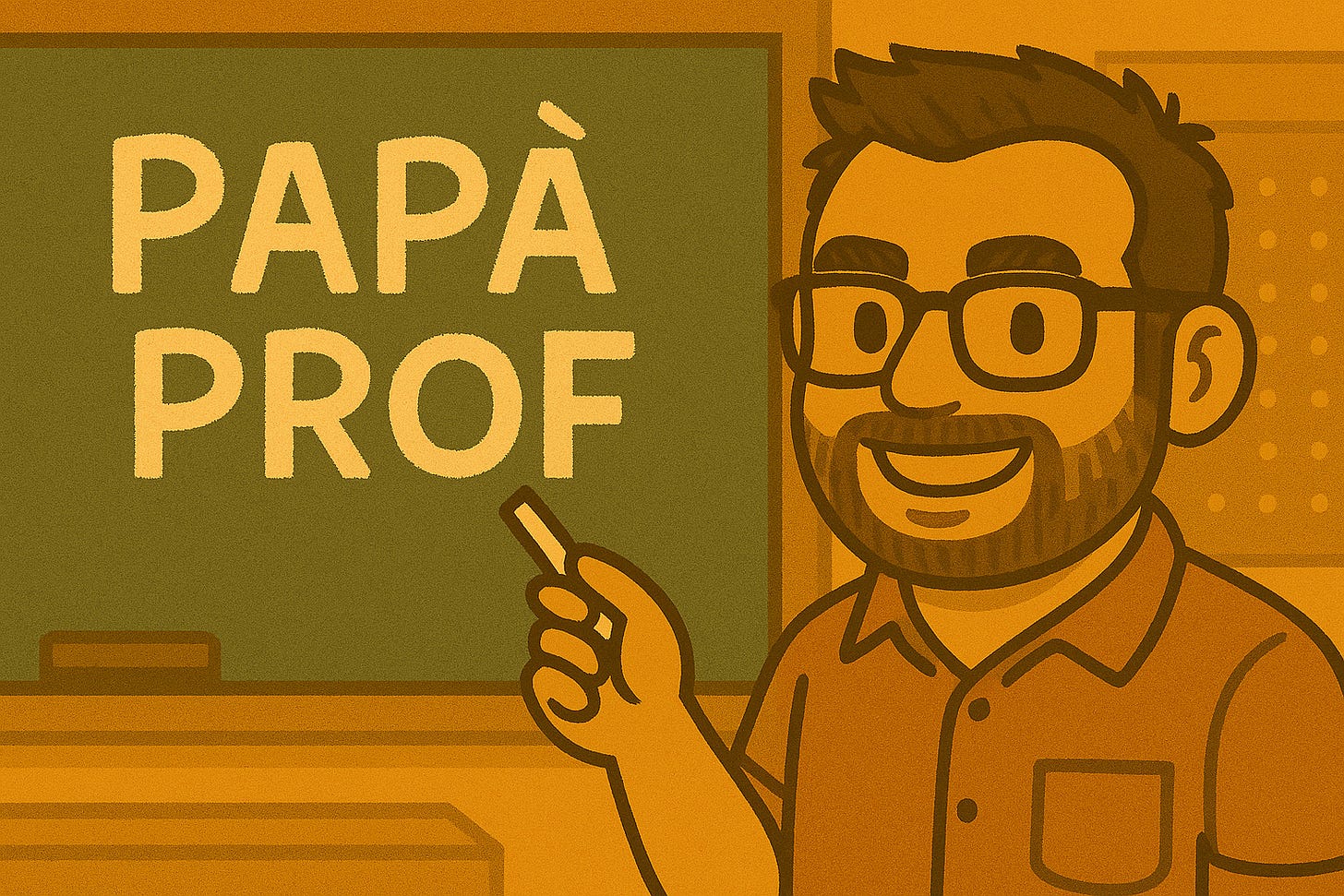
Grazie! Quanto è difficile l’ascolto attivo, è una cosa che bisogna coltivare e imparare e anche quando “ne sai” non sempre ti riesce… ma chi lo fa con ə figlə poi riesce a farlo anche con le persone e mi pare il primo fondamentale mattoncino per costruire un mondo migliore ❤️
Evviva la capacità di far nascere soli all'ora di cena e di stimolare nei ragazzi (e nei genitori che leggono) la necessità di essere ascoltati e di ascoltare.